Il GH e i pesci
Adesso ci occupiamo di osmoregolazione.
Ogni pesce è adatto alle durezze dell’acqua nella quale vive.
I pesci di acqua tenera vivono in un ambiente che ha una concentrazione di sali molto inferiore a quella interna al loro corpo.
A causa dell’osmosi dovrebbero continuamente riversare sali in acqua e assorbire una quantità spropositata di liquido; in sostanza, dovrebbero morire in breve tempo.
Tuttavia, la loro fisiologia impedisce che questo accada: non bevono acqua, producono abbondante urina molto diluita e i loro reni trattengono parecchi sali.
Hanno inoltre numerose proteine specializzate, situate in particolare sulle branchie, che riescono a trasportare attivamente i sali dall’ambiente esterno verso l’interno del pesce, operando contro il gradiente di concentrazione.
I pesci di acqua ricca di sali, come quella del mare, vivono invece in un ambiente nel quale i sali esterni al loro corpo sono molti più di quelli all’interno.
A causa dell’osmosi dovrebbero rilasciare tutta l’acqua del loro corpo e assorbire grandi quantità di sali.
Questo però non accade, perché bevono molta acqua ed espellono grandi quantità di sali producendo poca urina molto concentrata, mantenendo così l’equilibrio osmotico che permette loro di vivere.
Attenzione! Alcune specie, definite eurialine, riescono a vivere in entrambi gli ambienti, adattando il loro organismo alle differenti condizioni esterne di salinità: pensiamo ai salmoni, che per riprodursi tornano dal mare ai fiumi nativi, oppure agli squali e le altre specie che popolano gli estuari.
Tra le specie eurialine, ce n’è una in particolare che è ben nota agli acquariofili: i Guppy, che sono stati ritrovati in acque con durezze in confronto alle quali la nostra acqua demineralizzata è «dura»; ma anche in acqua salmastra!
Nel loro caso le durezze sono praticamente irrilevanti anche se vengono considerati pesci da acqua «dura».
Fatta eccezione per queste particolari specie, la maggioranza dei pesci ha sviluppato una fisiologia che permette loro di vivere al meglio in un ristretto range di salinità.
Anche considerando solo l’acqua «dolce», per la quale la salinità è sempre inferiore a quella presente all’interno del pesce, c’è comunque una differenza significativa tra l’acqua quasi demineralizzata del Rio Negro e quella, ad esempio, del lago Tanganica.
Le specie che popolano uno dei due ambienti non potrebbero vivere nell’altro!
Insomma: se il pH ci interessa relativamente, le durezze ci interessano decisamente.
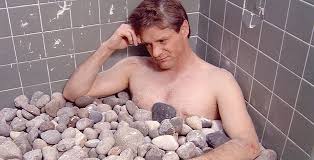
Ma… quali durezze? La durezza totale, che misuriamo con il test del GH?
Le cellule dei pesci scambiano con l’ambiente una gran quantità di elementi: sodio, potassio, cloro, idrogenioni, bicarbonato, ammonio…
… ma il test del GH misura solo calcio e magnesio (anzi, soprattutto calcio)!
La conclusione è che il test del GH ci aiuta solo parzialmente a capire se la quantità di sali presente nella nostra acqua sia ideona alla fisiologia dei nostri pesci.
Il GH e le piante
Anche nel caso della durezza generale, come per il pH, se parliamo di piante il discorso cambia.
Le variazioni del GH ci aiutano a valutare la quantità di calcio assorbita dalle piante; il confronto tra dGH e dKH ci indica quasi sempre quanto magnesio abbiamo in acquario.
Sappiamo infatti che:
- il magnesio deriva principalmente da solfati: incide molto sul GH e pochissimo sul KH;
- Il calcio deriva principalmente da carbonati: incide in egual misura su entrambi i valori.
Ne consegue che:
- se c’è un ampio scostamento tra le durezze, probabilmente l’acqua è sufficientemente ricca di magnesio;
- se invece i due valori sono vicinissimi, il magnesio è probabilmente insufficiente.